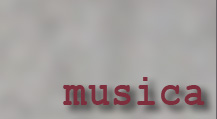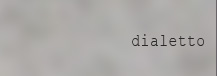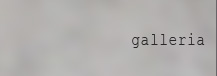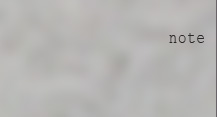RITORNO A LEUCADE
Lasciammo Leucade, la bianca isola del padri, il primo giorno del mese più caldo dell’estate: venti giovanetti da poco adatti al remo e venti fanciulle, tutti a Febo consacrati. Su tre piccole navi ci imbarcammo guidati da Archiloco il fratriarca, parte disposti con gioia e parte costretti a tale viaggio.
Disperati messaggi erano giunti, per voce di mercanti cretesi, dalla Sicilia. Laggiù, quindici anni prima, le genti di Leucade avevano mandato tutti i secondi nati che già avessero contratto matrimonio a dedurre, insieme con le famiglie, una colonia, a fondare una città, bella come la Nerico natia. Sorti contrarie, invece, avevano fatto in modo che sui nostri fratelli lontani Febo non risplendesse tanto benignamente, né fossero prosperate le mandrie, né le spighe dorate avessero piegato i loro steli gravide dell’opulento frutto. Più volte negli anni avevamo udito da mercanti di passaggio come essi, colti da continue sventure, avessero abbandonato l’impresa di edificare un tempio in pietra, e attorno ad esso la città.
Ora dal porto di Siracusa era giunto un appello chiaro: nuove forze venivano richieste. Gli ultimi raccolti erano stati buoni e si sperava in prossime fortune; necessitavano dunque giovani validi e donne in eta da marito, poiché molte erano state rapite dai Sicani dell’interno.
Dopo quindici giorni di navigazione, sospinti da venti favorevoli, approdammo alla costa meridionale della Sicilia presso Gela. Seguendo le indicazioni degli abitanti ci spingemmo ancora a ponente fino a quello che doveva essere stato il villaggio dei nostri sventurati fratelli; ma, poi che vi fummo giunti, trovammo che ad abitarlo non vi era rimasto piü nessuno.
In tal modo, sebbene non avessimo ancora l’età per essere considerati adulti, le leggi patrie che proibivano il ritorno da un viaggio colonizzatore prima di sei anni ci costrinsero a rimanere. Poiché così veramente era: non potevamo tornare! Accanto alle precedenti rovine, allora, edificammo con maggior fortuna una piccola e ben munita città a cui ponemmo nome Azia ed ivi, sotto la protezione di Apollo Fratore, divenirnmo uomini fatti. Ben presto scordammo Leucade. Le fatiche che ci furono compagne in tutti quegl’anni, pur colmi di esiti felici, distolsero le nostre menti dalla bianca terra dei padri. Avemmo un re, o meglio così uno di noi fu chiamato, una reggia, e crescemmo uno stuolo di figli degni della stirpe di Eracle.
Ben triste tuttavia fu, Archimaco,
la nostra sorte: tra di noi nessuno,
da Leucade partito giovinetto,
la sacra benda aveva ricevuto
e la scienza di celebrare il rito.
Come fuscelli eravamo sospinti
dal vento, navi in cerca di rifugio,
né in terra sacra la pianta affondava
né al cielo protendeva le radici.
Certo le messi empivano i granai;
La Parca oziava presso i nostri fili,
e in pace giorno seguitava a giorno;
certo non pativamo la sventura;
ma che cos’è in terra l’abbondanza,
Archimaco, che cosa la ricchezza
se non è benedetta dagli dei?
È il frutto che si ruba ai fati, è quanto
noi ignoriamo se è dato di raccogliere
anche soltanto ai figli che verranno.
Privi d’un tempio eretto ai sacrifici,
senza che attorno a noi l’esigua terra
fosse racchiusa nel prescritto cerchio,
noi eravamo pari ad esiliati
che ognuno è libero di depredare;
eravamo dovunque e in nessun luogo,
facile preda alle funeste Erinni.
Nulla è infatti la vita degli uomini
se il sacro gesto non le dà misura
La voce del padri, i racconti che avevamo udito nell’infanzia, le storie che gli aedi di Tessaglia narravano, erano un ricordo lontano oramai; né vi era alcuno che venisse a cantare alle nostre sponde.
Svaniva serena
del padri l’immaglne
e piano l’oblio
i cuori stringeva.
Svaniva la dolce
memoria di Leucade.
Ricordi, Filarete, quando, fattosi silenzio nella sala, egli toccava le corde prima d’invocare la musa?
E ricordi quanto a lungo col fiato sospeso si restava nol fanciulli quando il Pelide prolungava l’attimo mortale su Ettore ferito? Erano quelli antenati ben valorosi e ascoltavamo con il piacere misto all’orgoglio le loro gesta. Ad Azia, invece, nessuno che ci rammentasse le nostre origini, nessuno che con rustica eloquenza o col canto delizioso narrasse la storia della progenie di Eracle, nostro invincibile padre. Così anno seguitava ad anno.
Sinché un giorno dall’Ellade una nave
tre sacri messaggeri ci condusse:
tre vele mosse da un vento celeste:
ai cuori tre dolcissime speranze.
Tre fratelli giunsero alla mia terra:
volle il primo il cerchio tracciare,
il secondo il centro additare,
ed il terzo la voce annunciò…
In capo a nove giorni, su nave Corinzia, sarebbe approdato ad Azia un aedo di Larissa.
…e fu dolce stare,
insieme loro stare,
mentre s’attende chi
viene dal mare.
Noi la voce divina attendevamo,
l’ispirato celeste che i sussurri
ode del Citaredo e della Musa.
Dalle sfere celesti, discendi o fuoco!
Danzano le immagini del nulla, a folle danzano!
Giunse l’atteso il nono sorgere del sole, e furono apprestati i cibi alle mense. Adunati nella cinta regale, vedemmo accendere dai tre santi messaggeri il fuoco sacro; e il primo e più vecchio tra essi compi i sacrifici, e il fumo grato agli olimpi saliva rapido al cielo sereno.
Ma s’arresti la danza del tempo!
Giunto è l’ospite sacro!
Giunto è l’ospite sacro!
Giunto è l’ospite sacro!
Entrò nella reggia in venerabile silenzio e s’appressò al centro dove quietamente bruciavano verdi rami d’alloro. Ne aspirà il profumo e indi, volto a Ermegisto, nostro signore, ringraziò con parole miti e pie. Allora colui che sedeva al trono, solennemente lo accolse e lo invitò a cantare.
Dolce aedo Tessalo,
canta l’antica guerra!
Gl’invitti eroi raccontaci,
l’aspra e contesa terra
dove le nobili stirpi
del figli d’Elleno
ad Ilio turrita
posero assedio,
dove di sangue
fu rosso Scamandro
e le mura superbe
di fiamme dell’orrido incendio!
O generoso tempo degli eroi da cui discendono gli usi e le leggi! Gesta famose degli antichi padri! Dolce è ancora sentirvi rammentare, e dolce è poter dire noi siam parte di quanti a Troia scesero in battaglia, noi parte dei magnanimi e dei fieri.
Allorché l’aedo fu invitato a cantare, ognuno ebbe il cuore colmo di gioia poiché sentiva cosi di essere ritornato in patria, sentiva di poter riabbracciare i fratelli, di esser nuovamente guardato dagli dei. Solenne allora si fece il silenzio.
Si sedette l’aedo al convito
e col gesto prescritto dal rito
la sua cetra sonora toccò.
Cominciò a cantare:
il cielo ad invocare,
l’alto Signor dell’arco,
il dolce iddio del canto
e del mistero.
Sottilmente, allora, pervase gli animi un sacro timore e l’aria si fece intensa e luminosa.
Eh, sfolgorante Febo, altissimo signore!
Eh, nume splendente, amico superbo e fiero!
Tu la danza del mito riaccendi!
Dona luce al mio canto!
Allorché il nume fu invocato l’aedo chiuse gli occhi, e sembrò che con gran fragore gli eroi armati, i nostri padri stessi, scendessero tra di noi splendenti e vittoriosi.
Eran le genti d’Eliade
scese sul campo in guerra.
Il principe del Mirmidoni
l’asta omicida afferra:
orrida strage
di Teucri superbi
egli compie dinanzi
alle porte di Troia famosa.
L’invulnerabile figlio di Teti
ha scelto la giovane morte gloriosa.
Ettore figlio di Priamo
della stirpe di Dardano
s’erge a possente difesa;
reggon le sorti dell’aspra battaglia
dal candido Olimpo
i numi a contesa.
Cosi il canto si protrasse lungo tutto l’arco del giorno e, tra l’una e l’altra vicenda, allorché il poeta posava la cetra, ognuno si mostrava lieto e si cibava delle vivande apprestate e beveva il vino della mensa d’Ermegisto.
Quando il sole tramontò si accesero altri fuochi e si fecero danze in onore degli ospiti e si suonarono i flauti. Molti di noi, avvicinatisi all’aedo, trattandolo con molta reverenza, gli chiedevano notizie della patria lontana e delle altre città dell’Ellade; e tutti avevano risposta poiché egli era uomo di grande sapienza, e conosceva molto per il grande viaggiare che faceva.
E cosi sopravvenne la notte,
e dormimmo come dormono gli uomini
grati agli dei.
Un’ora prima dell’alba, quando ogni cosa era ancora immersa nelle tenebre, i tre messaggeri vennero a svegliarci: te, o Filarete, il Tiride Archiloco e me. Con brevi parole ci ingiunse di partire, né ci fu dato modo di replicare al loro misterioso comando.
Appena il cielo si fece bianco
le navi presesero il mare in silenzio
e noi lasciammo i figli per salpare
alla volta dei padri, per tornare
donde, fanciulli, eravamo venuti.
Dieci giorni durò il nostro viaggio,
nove giorni il travaglio del saggio.
Il primo giorno apparve Artemide,
ed il secondo l’alato Ermete;
il terzo venne dolce Afrodite,
il quarto giorno Iperione.
Il quinto, in armi, Ares fu guida.
Di Zeus il sesto l’aquila venne.
Cronos il settimo d’oro splendeva,
l’ottavo giorno l’ampio stellato,
il nono udimmo il suono beato.
Ma la più bella di Ionio, la perla,
il decimo apparve dinanzi alla prora:
Leucade, alta di candidi scogli,
ci accolse di Febo splendente all’aurora.
Chiaro udimmo il suo canto!